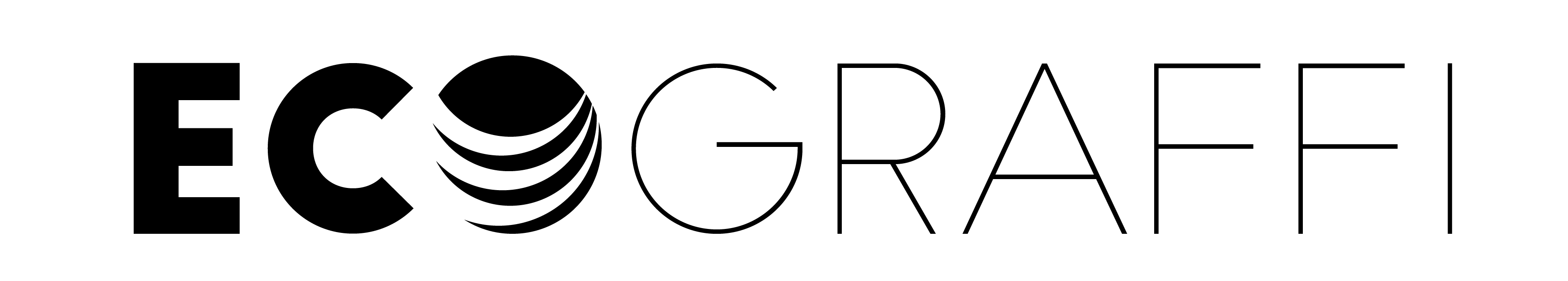Maria Ausilia Di Falco
Quando la pandemia è piombata su di noi, ci siamo sentiti tutti Gregor Samsa. Un giorno eravamo uomini liberi di uscire nel mondo là fuori e l’indomani un virus con la corona ci ha trasformato in immani insetti troppo ingombranti per stare chiusi dentro a una stanza.
Tutti distesi sul dorso, il corpo duro come una corazza, il ventre bruno diviso da nervature arcuate, le numerose zampette esili … abbiamo smesso di camminare e abbiamo iniziato a strisciare sulle pareti, ogni tanto abbiamo provato a sgusciare sul tetto ma il rischio di cadere era alto, troppo alto per insetti senza ali incapaci di gioire dell’esperienza del volo. E allora l’unica soluzione era la stanza. Non più la nostra stanza, luogo di rifugio, ma la stanza imposta, luogo di costrizione e catene, in una casa dove pure ai nostri genitori iniziava a importare poco di noi, non più figli ma ingombri. E così, via di avanzi, abbiamo perso pure il gusto, la fame di vita e l’unica via di fuga pareva un viaggio nell’aldilà.
Questa è senza alcun dubbio la favola più orripilante dell’immobilità dell’uomo moderno, sterile proprio come Gregor Samsa –se non di più, famoso protagonista de La Metamorfosi di Franz Kafka, fantasmagorico racconto che dopo un centinaio di anni torna a raccontarci qualcosa di molto attuale.
Noi poveri insettacci, non riusciamo neanche a chiamare aiuto. È un grido muto quello che cresce dentro di noi, creature Munchiane perdute in un Tempo tutto uguale, confinate in un gomito di mondo a ricordare il lavoro che lavoravamo, i viaggi che viaggiavamo; la gente che andava e veniva, le storie che incontravamo, le cose che ci appartenevano. È tutto un Tempo Imperfetto, è inutile che facciamo finta che. Davanti a una finestra aperta non sentiamo più neanche l’aria che frizza, ci siamo abituati ai tramonti che non sfumano più di colore, sfumano la vita lentamente in un ipnotico susseguirsi di epiloghi. Non esiste più il simbolo dell’inizio. C’è solo una fine dopo l’altra che si deposita anche sulla pelle diventata corazza e che trapassa le ossa, gli organi, ogni strato di quel che resta di noi.

Tutti noi, da quando ci svegliamo, ci pentiamo. Non sappiamo bene di cosa ma ci svegliamo già pentiti. Poi un giorno succede il peggio e allora rimpiangiamo il passato che avevamo, tutto il bello che c’era sotto ai nostri occhi e di cui non ci accorgevamo. Quando Gregor inizia a capire che il peggio è arrivato e dentro a quella nuova forma deve starci, forse se ne fa pure una ragione e inizia a sperimentare un nuovo sapore per la solitudine, il piacere dell’autodistruzione, una sorta di entusiasmo della paura, l’entusiasmo di passare da dominatore a dominato, di non dover decidere più. Capisce che è pur sempre vivo e prende le misure di questa nuova avventura, prova a cucirsi addosso un nuovo abito. Non ci riesce, prova a vivere nudo. Dopo tutto, accanto alla sua stanza può ancora sentire il violino suonato da sua sorella e ritrovare una sensazione di pace, non serve altro.
Come la mettiamo però con gli altri? Dalla stanza accanto giungono anche le voci lamentose di una madre e un padre disperati, perché se siamo diventati insetti come Gregor, chi andrà a lavoro? Chi porterà i soldi a casa? Chi manderà avanti la baracca? Che vita sarà senza i mezzi giusti per viverla?
Il coronavirus non ci ha solo tolto il lavoro e immobilizzato, ci ha spettinato i pensieri: ha confuso i contorni dei giorni, abbassato la temperatura delle nostre emozioni, acuito i nostri dubbi e in questa incertezza ci ha reso così tanto disperati che non ci importa più d’essere vivi. A che serve essere vivi se si vive chiusi se si vive male o a metà.
Qui arriva il senso della metamorfosi. Ci immedesimiamo in Gregor, ci crogioliamo, ci disperiamo, ci alieniamo, pensiamo è finita. E in questo rotolo di negatività diventiamo inaspettatamente portatori sani di resistenza umana. Ci trasformiamo contro le nostre aspettative. Essere insetti non è così male, è solo sinonimo d’essere diversi. Ci trasfiguriamo e nel contesto animale rintracciamo una qualche forma di amore bestiale. Nel ribrezzo assoluto, il ricordo del passato ci sembra bellissimo e dall’energia dell’errore tendiamo a trarre un insegnamento per il futuro.
Del resto, andando ancora più indietro nel tempo, Lucio nelle Metamorfosi di Apuleio, non diventa forse un asino che nel processo di ri-trasformazione umana, acquisisce una grande consapevolezza di sé e rilancia il suo futuro?

Evidentemente c’è un senso nello stare. Nella immobilità. Nella sospensione del tempo. Ce lo sussurrano senza tergiversazioni, le Metamorfosi di Philip Glass che, musicalmente parlando, sono una purificazione mentale, un rinnovo cellulare a cui il nostro corpo giunge dopo avere ascoltato sfumature di sfumature di note, acquisito suoni rinnovati come impercettibili onde, variazioni di microvariazioni, in un ciclo celeste eterno.
Nell’unione spirituale tra la musica e il nostro essere più profondo, c’è il ritorno al nocciolo dell’ascolto, dell’ascoltarsi; il minimalismo che non obbliga a processi cerebrali diventa suono terapeutico, una cantilena primordiale che rompe le incrostazioni, toglie la polvere, ripulisce dalle sofferenze, dalle lamentele e si fa cura. Lamentamorfosi: la lamentela si zittisce per dare spazio solo a quella speranza che alla fine del Tutto, ci porta all’origine della vita, come Lucio in Apuleio, come Gregor in Kafka. Che non sono uomini condannati –la metamorfosi non è condanna, è trasformazione, dunque sono uomini trasformati. Ne abbiamo testimonianza.
Questa drammatica testimonianza del nostro destino, riflette la complessità di un’epoca. Seppur per motivi diversi dal Novecento, anche in questo momento storico si avverte la dissoluzione totale dei confini tra gli uomini, gli uomini e le cose, gli uomini e il recinto del mondo. Sentiamo tutti un cosmico senso di esilio, il nostro unico palco è il Teatro dell’assurdo, la dimensione della quotidianità è mostruosa, abbandoniamo l’idea di una vita giusta per soccombere a un’inquietudine pessioniana. Il Tempo Imperfetto diventa una fame che non riusciamo mai a saziare. Osserviamo il nostro corpo come una gabbia, ne usciamo ossessionati. Quando tentiamo di uscire dal guscio della solitudine, l’arredo urbano ci sembra decadente, l’aria che respiriamo diventa gotica; sotto un cielo comunista ci sentiamo estranei. In questa geografia dell’assenza compriamo al mercato della nostalgia e tutto quello che vorremmo è la normalità. L’odiosa normalità di cui ci lamentavamo sempre. La cenere dell’indeterminatezza ci strazia; ci credevamo paesani quando eravamo universali, adesso vorremmo scoprirci universali e invece siamo solo banali. Nel teatro dell’assurdo, ci guardiamo intorno per non vedere nessuno, per scoprire che tutto quello che volevamo vedere ce lo avevamo già. Beckett ci viene in soccorso Non posso continuare Continuerò, dobbiamo imparare a recitare un copione inedito.
Forse allora non dobbiamo uscire.
Dobbiamo scendere. Negli abissi, cioè nel profondo, quel profondo che non è colpa del virus se abbiamo perso. Quel profondo sostituito dalla superficie dei tasti della tecnologia, di un telefono che funziona solo se lo sfioriamo verso l’alto Touch non se lo premiamo verso il basso Press. Sarebbe un’immagine perfino poetica, l’alto, l’aria, il dito all’insù. Ma le cose che restano troppo nell’aria si addormentano per sempre nel velluto notturno, perdendosi. Le cose che durano, vanno toccate e premute, premute a lungo. Andare in giù per tornare in su.
“…Oscura chiarità, festoso inferno,
lucida frenesia, gioia impaurita,
riso nel pianto, brevità d’eterno,
trofeo e indice della mia vita …”
Patrizia Valduga docet.
Toccare il fondo, ingoiare il niente, digerirlo.
“…Che è questo vuoto quello che mi offende,
vuoto infinito, infinito niente,
un niente che dà niente e niente prende
nel niente di un tale niente di niente
che l’anima nel cuore fa tremare.
Tra nudi spettri e vane ombre e niente…
Non è cambiato niente. È cambiato tutto.”
Chandra Livia Candiani perseverat
Forse allora non dobbiamo uscire.
Dobbiamo aprire gli occhi.
Forse che aprendo gli occhi, è la luce che ci spaventa? Non siamo che abituati al buio adesso. Ma aprire gli occhi, spalancare le finestre, significa toccare il cielo e scoprire che il cielo arriva fino a terra e la terra tocca i nostri piedi. Significa che possiamo riacquisire uno sguardo nuovo che dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto semina, trattiene e restituisce bellezza.
“Abbiamo passato momenti
duri
ma poi
è uscito il sole
a darci felicità.
Noi siamo colline
e, piano piano,
ci abbassiamo.
Maestra,
il verbo restare
non è all’infinito.”
Il verbo restare non è all’infinito -parola di una bambina di cinque anni che scrive una poesia alla maestra Candiani. E il Tempo non è solo e sempre Imperfetto. Come ci insegna la maestra possiamo sentire la rabbia ma non sentirci arrabbiati, provare dolore senza essere addolorati, stare in silenzio ma non tacere, avvicinarci al fuoco senza bruciarci. Vivere la vita senza pianificarla.
Possiamo aprire gli occhi e scoprirci svegli. Né belli né brutti, né intelligenti né pronti, semplicemente svegli. Consapevoli.
Con-sappiamo per una volta, proviamo a consapevolizzarci insieme. Noi, Gregor, Lucio, le note di Glass.
Forse allora non dobbiamo uscire.
Non dobbiamo cercare questa benedetta via d’uscita.
La musica non cerca una via d’uscita, cerca una vita d’entrata. Se saliamo sulle note e viaggiamo sul sound, entriamo in un nuovo mondo, il momento è maturo. Diamo all’entusiasmo della paura il permesso di soggiorno. Non è abituarci a essere insetti, non è transito illusorio. Solo se impariamo a essere insetti, a stare, potremo sperare un giorno di svegliarci un’altra cosa, magari una farfalla. Trasformarci. È successo una volta può succedere ancora. Trasformarsi magicamente, dopo l’incubo, in uomini consapevoli e avviare una meravigliosa trasformazione sociale.
Forse che gli uomini consapevoli non hanno più paura? No.
Nel mistero dell’esistenza umana, Uomini e Insetti devono a convivere. Anche se nessuno ci promette la gioia, quello che abbiamo capito è che la gioia si trasforma in dolore e il dolore in gioia, sempre. Che in sostanza gioia e dolore convivono. Moriamo solo se muore la speranza.